PILLOLA N. 6
- Veronica Buscarini

- 22 giu 2020
- Tempo di lettura: 5 min

Questa pillola è parte della serie di pillole sulla progettazione narrativa. Ti consiglio di partire dalla prima, la pillola n. 3 e andare in ordine, potresti trarne più vantaggio.
Prima di cominciare a parlare di punto di vista vorrei partire da una fiaba: I ciechi e l’elefante.
Nella prima parte della fiaba si racconta di sei saggi ciechi e di un principe venuto da lontano che porta loro un elefante. I ciechi, desiderosi di sapere che cosa fosse un elefante, lo tastano e poi tornano al loro villaggio per raccontarlo agli altri abitanti.
Ecco cosa accade:
"Bè," disse il primo "un elefante è come un enorme ventaglio rugoso."
Gli aveva toccato le orecchie.
"Assolutamente no," intervenne il secondo "E' come un paio di lunghe ossa."
Gli aveva toccato le zanne.
"Ma proprio per niente!" esclamò il terzo "Assomiglia ad una grossa corda."
Gli aveva toccato la proboscide.
"Ma cosa state dicendo? Piuttosto è compatto come un tronco d'albero!" disse il quarto che gli aveva toccato le zampe.
"Non capisco di cosa state parlando..." disse il quinto "Un elefante assomiglia ad un muro che respira."
Gli aveva toccato i fianchi.
"Non è vero," gridò il sesto "Un elefante è come una lunga fune."
Gli aveva toccato la coda.
Questo breve estratto è una metafora perfetta per spiegarci l’importanza del punto di vista. Il punto di vista di una storia è un aspetto fondamentale della storia stessa, per questo motivo va scelto con massima cura.
Il punto di vista determina il modo in cui decidiamo di raccontare il pezzettino di mondo di cui parla la nostra storia.
Nel deciderlo operiamo una scelta che è sia grammaticale che narrativa.
Partiamo da quella grammaticale. Chi racconta la nostra storia?
Possiamo avere due tipi di punti di vista:
Esterno
Interno
Il punto di vista esterno può attuarsi attraverso un narratore onnisciente, ovvero informato totalmente sui fatti e a conoscenza di ciò che accade dentro e fuori i personaggi. Il più grande esempio di narratore onnisciente della nostra letteratura è Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi.
Ecco, un narratore onnisciente segue le fila di tutti i personaggi, e può farlo restando nascosto, oppure palesarsi e intervenire con commenti, spiegazioni, “a parte” in cui parla direttamente al lettore.
Il narratore onnisciente è molto utilizzato nella letteratura italiana e ciò cui bisogna fare attenzione quando lo si utilizza è di non essere eccessivamente presenti nella storia; bisogna lasciare spazio a chi legge, non dirgli tutto, permettergli di scoprire il racconto e fare le sue considerazioni. Calibrare cioè il detto e il non detto.
Il narratore interno invece segue a stretto contatto un personaggio della storia, di solito il protagonista, e lo si può fare in prima o in terza persona.
Questa è una scelta che va fatta con attenzione in quanto cambia visibilmente il tipo di narrazione. Un racconto in terza persona appoggiata inserisce un personaggio in più nella storia, ovvero il narratore. La vicenda è raccontata con la SUA voce, i pensieri del personaggio sono filtrati dal narratore. Questo inevitabilmente crea un distanziamento maggiore dalla storia e permette maggiori considerazioni su ciò che accade da un punto di vista esterno.
Attenzione però. Anche se abbiamo una terza persona se decidiamo di raccontare dal punto di vista di un personaggio non possiamo sapere ciò che accade ad altri se lui non è presente, non possiamo cioè comportarci da narratori onniscienti.
Se invece adottiamo la prima persona dobbiamo fare un grande lavoro di immedesimazione, diventiamo a tutti gli effetti il nostro personaggio scomparendo dalla vicenda. È il nostro protagonista che con la SUA voce racconta la SUA storia, per cui è necessario anche un’attenzione al linguaggio usato. Se ad esempio siamo nei panni di un bambino ciò che accade andrà raccontato con la voce di un bambino, filtrato dalla sua fantasia e dal suo modo di vedere il mondo.
Altri punti di vista con i quali però è molto complesso cimentarsi sono il noi e il tu.
Se si utilizza il “noi” si ha più protagonisti e si dà una dimensione di coralità alla storia, mentre con il tu si ha una forte intimità tra due personaggi, chi racconta e di chi parla. Il personaggio che racconta la storia è totalmente appoggiato a quello cui si rivolge in quanto racconterà la sua vicenda che, molto probabilmente, lo vede fortemente coinvolto.

Cambiando il punto di vista avremo una storia diversa. Pensa a Cappuccetto Rosso, la storia che conosciamo è raccontata totalmente dal punto di vista di una ragazzina con un cappuccio rosso che vuole raggiungere casa della nonna ma si perde nel bosco incontrando il lupo.
Abbiamo pochi personaggi: cappuccetto rosso, il lupo, la nonna e il cacciatore.
Un esercizio divertente che potresti fare è di provare a raccontare la stessa storia dal punto di vista di ognuno di questi personaggi; ovviamente ci saranno alcuni aspetti della storia che non potrai raccontare e altri che non conosci e dovrai aggiungere da te. E il risultato? Avrai quattro storie diverse.
Se stai cominciando a scrivere un romanzo è molto probabile che una volta che avrai pensato al tema, la trama e i personaggi avrai anche ben chiaro chi sarà il protagonista.
A questo punto dovrai decidere se raccontare la storia con un narratore onnisciente, ideale se vuoi seguire le fila di più personaggi, o interno.
Il modo migliore per capirlo è fare delle prove. Pensa ad una o più scene, l’incipit o altre parti del tuo romanzo e prova a raccontarle adottando un punto di vista onnisciente, una terza persona appoggiata, una prima persona, ecc.
Fai diverse prove e vedrai che ogni volta ci sarà un punto di vista che troverai più spontaneo e naturale da utilizzare. Ecco, quello è il punto di vista giusto.
Una volta deciso chi racconta la nostra storia è bene considerare anche altri aspetti, sempre parte della definizione del punto di vista, ovvero quando e dove.
L’ambiente in cui viene collocata una storia così come la scelta del tempo del racconto sono determinanti per rendere l’atmosfera del racconto, il colore, quell'insieme di aspetti in grado di rendere una serie di sensazioni che il lettore terrà con sé anche a distanza di anni.
La scelta del luogo è un aspetto importante per l’atmosfera che circonda una vicenda, è molto probabile che tu ci abbia già pensato definendo la trama e i personaggi. Che il tuo racconto avvenga in una scuola, in un ufficio, in campagna o in città è determinante quasi quanto un personaggio in più.
Allo stesso modo se racconti una storia nel presente o nel passato darai informazioni completamente diverse. Il presente conferisce al racconto una simultaneità con gli eventi narrati, tutto accade ora mentre te lo sto raccontando, mentre la scelta ad esempio del passato remoto ci dice che ciò di cui parlo è accaduto ai personaggi molti anni prima.
Come vedi sono tutti aspetti che incidono nel racconto stesso, in modo implicito aggiungono informazioni in più alla vicenda per cui è bene definirli con calma, prendendosi il proprio tempo, interrogandosi su cosa si vuole dire e come e soprattutto facendo prove.

È fondamentale provare, scrivere scene in modi diversi, cambiare il punto di vista, sia per capire ciò in cui ci sentiamo più a nostro agio, sia per entrare in confidenza con la storia che vogliamo raccontare, stimolare la nostra creatività, trovare altri spunti e idee che ci serviranno per raccontarla.
Spero che questa pillola ti sarà utile, se hai dubbi o domande contattami in privato oppure commenta l'articolo.
Alla prossima!







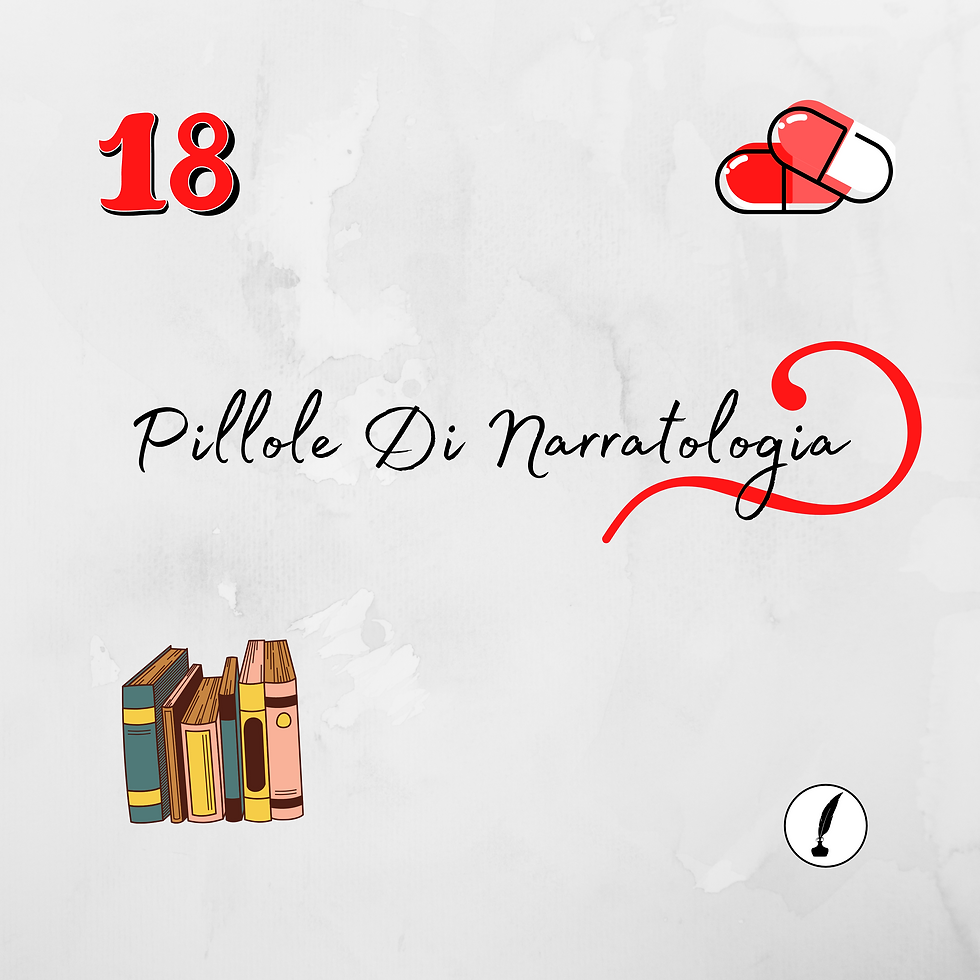
Commenti